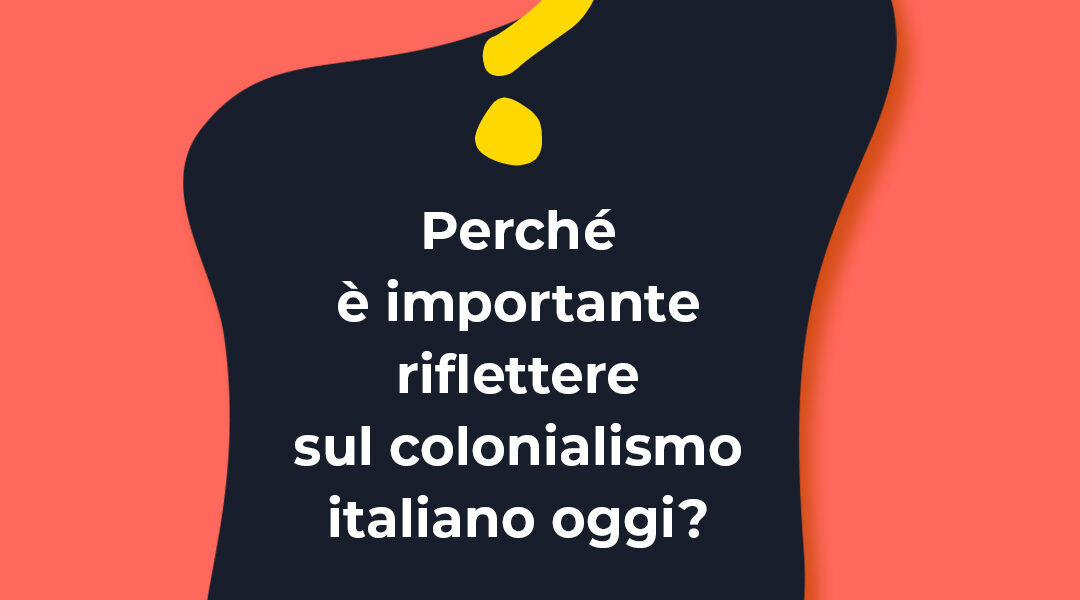
Perché è importante riflettere sul colonialismo italiano oggi?
La storia può assumere una valenza del tutto diversa in base a quali fonti vengono utilizzate per raccontarla, ma come afferma lo storico postcoloniale Michel-Rolph Trouillot: “il passato non esiste indipendentemente dal presente…il passato è una posizione (nel tempo) e in nessun modo possiamo identificare il passato (solo) come passato”*. La storia di Elsabiet fa riflettere su un capitolo della storia italiana che tutt’oggi non è parte di una memoria storica e collettiva: il colonialismo. L’Italia è stata una potenza coloniale per circa un secolo, dal 1868 – anno della convenzione di Assab – al 1960, anno in cui 17 stati africani riconquistarono la loro indipendenza. Tra questi, vi era anche la Somalia su cui l’Italia aveva ancora un mandato e in cui al tempo risiedevano ancora più di dieci mila italianƏ.
Sin dai primi decenni di occupazione, l’Italia è stata artefice di crimini di guerra e massacri perseguendo strategie di sterminio e sottomissione delle popolazioni in Eritrea, Etiopia, Libia e Somalia. Per ricordare solo alcuni dei momenti più cruenti vi sono le stragi di Dogali e Adua, rispettivamente nel 1887 e 1896, le operazioni di sterminio contro le popolazioni Oromo e Amhara, il genocidio della popolazione araba in Libia tra il 1929 e il 1934 mediante uccisioni, operazioni di carestia organizzata e l’istituzione di campi di concentramento. Quest’ultimo seguito anche da una campagna di cancellazione di documenti storici. Infine, il massacro di Addis Abeba del 1937, noto per la sua violenza inaudita. Negli anni migliaia di italianƏ si trasferirono nelle colonie determinando una vera e propria colonizzazione demografica e urbanistica di città come Asmara, Mogadiscio e Addis Abeba in cui i nomi di strade e piazze riportavano la propaganda fascista di glorificazione della vittoria imperiale. Allo stesso modo, in molte città italiane sono tutt’ora presenti strade, piazze, targhe e monumenti che lo ricordano. Così, i crimini e le atrocità del colonialismo sono rimossi dalla coscienza pubblica e collettiva e diventano semplici nomi ignoti e lontani. Inoltre, vi è una mancata consapevolezza della presenza sul territorio italiano di persone africane da sempre, e di persone eritree sin dai tempi del colonialismo.
L’occupazione militare fu affiancata dall’imposizione della lingua e cultura italiana e il tutto fu giustificato all’opinione pubblica mediante l’idea di una superiorità razziale che in passato ne deresponsabilizzò le azioni, e su cui oggi non si è ancora riflettuto abbastanza. Con le leggi razziali degli anni ’30, le operazioni di segregazione etnica aumentarono e dal 1937, a differenza di ciò che era avvenuto fino ad allora, le relazioni tra persone locali e italiane vennero vietate e sanzionate, ai padri fu vietato di riconoscere figlƏ e dare il cognome italiano. Anche dopo l’abrogazione delle leggi fasciste, migliaia di persone non videro riconosciuta la cittadinanza italiana. Tuttavia, il passato coloniale italiano è stato messo da parte e dimenticato troppo velocemente. Secondo alcunƏ storicƏ, ciò è accaduto perché del colonialismo è rimasta una memoria di vergogna data dalla sconfitta militare che ne decretò la fine. Inoltre, nessun italiano è stato mai processato per i crimini compiuti nelle ex-colonie anche se nel 1946, durante i lavori della Conferenza di Parigi, l’Etiopia presentò richiesta di riconoscimento dei crimini compiuti dall’Italia.
Oggi vi è una mancata presa di coscienza verso i crimini e le azioni commesse che, sono state collettivamente rimosse e non inserite in libri scolastici. La deresponsabilizzazione delle azioni italiane impedisce una riflessione sulle ferite profonde lasciate e, sul sistema politico, culturale e sociale di paesi che oggi sono anche territori di alti flussi di emigrazione verso l’Europa. La mancata condanna, e successiva riflessione, sul colonialismo determina tutt’oggi la presenza di schemi razzisti collettivi che si manifestano da un lato, in concetti, narrazioni e categorizzazioni della popolazioni e in scelte politiche dall’altro.
Solo mediante la decostruzione del passato, responsabilità passate e presenti possono emergere e arricchire il dibattito sull’identità italianƏ che non può essere sconnessa con il suo passato coloniale e razzista. Oggi Yekatit 12 -19 febbraio, rete italiana che organizza numerose iniziative contro la rimozione della memoria collettiva del colonialismo e i suoi crimini, propone di instaurare una Giornata della Memoria in ricordo delle vittime del colonialismo italiano il 19 febbraio che è tutt’oggi, in Etiopia, giorno di lutto nazionale in ricordo delle vittime del colonialismo italiano.
*“…But the past does not exist independently from the present. Indeed, the past is only past because there is a present, just as I can point to something over there only because I am here. But nothing is inherently over there or here. In that sense, the past has no content. The past — or more accurately, pastness — is a position. Thus, in no way can we identify the past as past.” (Trouillot, M-R., (1995). Silencing the Past: Power and the Production of History, p. 15).
Per approfondire, vi consigliamo la lettura di alcuni articoli che affrontano il tema in maniera critica e dettagliata:
- Gli articoli parte di Ritratt3 – newsletter a cura di Soda Morem Lo, parte del team di Scienza Migrante 2.0, e Gloria Napolitano – che vogliono raccontare le storie dimenticate di profili afrodiscendent3 d’Italia: https://substack.com/@ritratt3?r=2nkkml&utm_medium=ios&utm_source=profile
- I crimini e le vittime del colonialismo italiano: una storia tutta da raccontare a partire da Yekatit 12 የካቲት ፲፪
- Per una rilettura dell’esperienza coloniale italiana nel Corno d’Africa | Dialoghi Mediterranei
- L’Italia fascista e il genocidio libico dimenticato – Invictapalestina
- Postcolonial Italy – Mapping Colonial Heritage


